“Il” fine e “la” fine della vita. Omelia per l’ultima domenica del tempo ordinario
 Miei cari,
Miei cari,
oggi, ultima domenica del tempo ordinario, con la festa di Cristo Re dell’universo e Signore della Storia, si chiude il ciclo liturgico dell’anno A, e concludiamo la lettura del capitolo venticinquesimo secondo Matteo, che ci ha condotto nelle ultime due settimane, con la lettura dell’ultima delle tre parabole che abbiamo commentato e che riguardano tutte il “fine” e la “fine” della nostra esistenza terrena (Mt 25,31-46). Non è un gioco di parole, ma oggi siamo chiamati definitivamente a metterci in discussione attraverso due articoli determinativi, “il” e “la”, che mostrano pienamente il significato del termine a cui si accompagnano, “fine”. Nel primo caso, “il fine” rappresenta lo scopo per cui noi nasciamo, viviamo e concludiamo l’esistenza; nel secondo, “la fine” indica il modo con cui avverrà il Grande Giudizio Finale del Signore. Entriamo, dunque, nel brano, con tre sottolineature.
I Protagonisti coinvolti
La prima sottolineatura riguarda, anzitutto, i protagonisti coinvolti. Sono due il Giudice e i Giudicati.
L’evangelista Matteo descrive il Giudice, cioè il Signore Crocifisso-Risorto, facendo riferimento ad un’immagine tradizionale che il primo popolo dell’Alleanza, Israele, conosceva bene, il Re-Pastore. Scrive, infatti, l’evangelista Matteo: «Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra» (Mt 25,32-33). Quest’immagine del pastore richiama quanto abbiamo ascoltato anche nella prima lettura, tratta dalle profezie di Ezechiele: «Ecco, io stesso cercherò le mie pecore … Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore … Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. … Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia» (Ez 35, passim).
C’è un primo elemento che balza immediatamente agli occhi da entrambi i brani della Scrittura citati: la cura del Pastore. Egli compie un’azione di affetto per il gregge affidatogli, perché esso possa essere al sicuro dai pericoli, finanche, a rischio della stessa vita del pastore. È racchiuso in queste parole il mistero della nostra salvezza, la Pasqua, che si è compiuto nella Passione-Morte-Resurrezione del Pastore, che per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal Cielo, si è fatto uomo, ha sofferto, consegnandosi volontariamente alla morte e, con il suo amore divino che non conosce misura e confini, ha offerto la sua vita, perché ricevessimo la vita in abbondanza (Gv 10,10).
C’è poi una seconda azione che compie il Pastore divenuto Re, il “discernimento”, assumendo su di sé la signoria su tutte le cose. Come dice, esordendo, l’evangelista Matteo: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria». Il Pastore, che ha dato la vita, ritorna ora come Re nella gloria con i segni della sua passione e risorto da morte possiede la signoria su tutto il creato. Ha, così, il diritto di separare le pecore dalle capre, i buoni dai cattivi; infatti, secondo la mentalità di allora, le pecore, che non sono autonome e più fragili, sono il simbolo di coloro che seguono e obbediscono a Cristo, mentre le capre, più indipendenti e meno delicate, rappresentano coloro che non hanno scelto di seguire Gesù e il Suo esempio sulla terra.
C’è infine un terzo particolare, forse meno evidente dei primi due, che riguarda il secondo protagonista, quello che subisce la cura e il discernimento del Re-Pastore, giudicato dalle azioni compiute come giusto o empio: questi non è solamente il credente in Cristo, ma, come dice chiaramente il testo, sono tutti gli uomini e tutte le donne, come viene esplicitato dall’evangelista Matteo: «Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli» (Mt 25,32). Da questo si deducono due conseguenze. La prima: che il Dio di Gesù Cristo è Dio di tutti gli uomini e le donne, senza alcuna distinzione. C’è un bellissimo inno a Cristo, contenuto nella lettera di san Paolo ai Colossesi, certamente un canto che si proclamava nelle assemblee liturgiche del I secolo, che esprime con chiarezza la signoria di Cristo sull’intero creato: «[Gesù] è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,15-20). Emerge, poi, nitidamente una seconda conseguenza. Se nessuno può dirsi estraneo a Dio ed è oggetto della sua cura amorevole, nessuno sarà assente anche dal discernimento finale, per un giudizio di salvezza o di dannazione eterna.
Questo scritto finora ci porta alla seconda sottolineatura che voglio fare del brano evangelico di oggi, e che ho definito “il fine” della nostra vita terrena.
“Il fine” della vita terrena
“Il fine” della vita terrena è, infatti, il secondo rilievo, che scaturisce dalle domande fondamentali che riguardano ogni uomo e ogni donna, che vive in questo mondo: Chi sono io? Da dove vengo? Dove sono diretto? Da dove viene il mondo? C’è una vita oltre quella che viviamo sulla terra? Perché al mondo ci sono il dolore e la sofferenza?
A queste grandi domande, che descrivono bene il dramma dell’esistenza di ogni uomo e di ogni donna su questa terra, il Re-Pastore, nel brano odierno, dà un’unica risposta: l’amore
Questo amore immenso, che è più profondo di un sentimento, è la stessa vita di Dio, come insegna l’apostolo Giovanni: «Dio è amore» (1Gv 4,7), dalla quale ogni essere proviene, con la quale ogni persona vive e verso la quale confluisce ogni esistenza.
Dio l’ha mostrata chiaramente nella vita del Figlio Amato, il Crocifisso-Risorto. Crocifisso, con una morte ignobile, scelta per la salvezza dell’intero universo, senza alcun ricatto, senza alcuna condizione, dopo aver condiviso con la stessa umanità le situazioni descritte nel vangelo da Matteo: «ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,35-36). Crocifisso ma Risorto, perché dal sacrificio del Figlio, segno dell’incommensurabile amore divino, è scaturita la vita divina per tutti gli uomini e le donne, quella vita che non conosce né fine e né limite, ma travalica l’ombra di ogni morte materiale e spirituale. Come è stato proclamato nella seconda lettura di oggi per bocca dell’apostolo Paolo: «Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita» (1Cor 15,20-22).
Di questa esperienza di amore smisurato è intessuta la vita di ogni uomo e di ogni donna, non solo perché creati ad immagine e somiglianza di Dio in Gesù Cristo ma perché viventi di questa fondamentale relazione, che ne siano consapevoli o no. Proprio l’esserne o meno consapevoli non fa alcuna differenza; lo si nota dalle domande di stupore che sia i giusti sia i dannati rivolgono al Re-Pastore: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» (Mt 25,37-39; 44-45). Per entrambi la risposta è lapidaria: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). È l’aver fatto ciò che è stato richiesto, consapevolmente o no, a determinare per gli uni la salvezza, per gli altri la dannazione.
Per credenti in Cristo e per tutti, dunque, “il fine” della vita consiste in una vita vissuta nell’amore, che si può manifestare in due atteggiamenti: la filantropia o la carità cristiana. Non sono sinonimi, ma modi di vivere l’amore diametralmente opposti. Infatti, la filantropia è un sentimento e un conseguente atteggiamento di benevolenza alla base di un comportamento diretto a realizzare il benessere altrui secondo criteri di giustizia. È un sentimento nobile, ma che differisce profondamente dalla carità cristiana perché la benevolenza è esercitata sulla base della giustizia umana: faccio del bene a chi mi vuol bene e mi attendo il contraccambio. La carità cristiana no: ama a prescindere. Gesù ce lo chiarisce bene in un celebre passo: «Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi» (Lc 6,32-35). Questa è la chiave di lettura esatta della carità cristiana che si concretizza nella predilezione per gli ultimi e per i più piccoli, che vanno amati allo stesso modo con cui Dio ama e, soprattutto, perché è presente in questi il Crocifisso-Risorto.
Ma in «questi miei fratelli più piccoli» sta anche la porta che conduce tutti alla salvezza. Essi sono l’occasione di grazia attraverso la quale si rende presente il Verbo fatto carne, dalla cui pienezza riceviamo «e grazia su grazia» (Gv 1,16). Gli ultimi, perciò, non vanno scelti in quanto tali, ma in quanto in essi vive Cristo, in cui «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9). Essi diventano per questo la Porta che conduce al Paradiso, che “il fine” della nostra vita.
“La fine” dell’esistenza
Infine, veniamo alla terza sottolineatura: “la fine” della nostra esistenza terrena.
Essa, come appare chiaramente dal vangelo odierno, sarà determinata da questo amore disinteressato, divino, al limite della umana immaginazione, perché giunge ad amare i nemici. Solo Dio può compiere tanto; ma l’uomo lo può fare se unito a Cristo mediante la grazia effusa nei Sacramenti, come si diceva domenica scorsa a proposito dei talenti.
Dunque, come credenti ci sono stati consegnati i mezzi per adempiere a tutto ciò. Qui si giocherà “il fine” della nostra esistenza, che ci porterà alla “fine” della vita per un giudizio di salvezza o di dannazione. Essi saranno eterni, proprio perché la vita è un fatto serio ed unico, irripetibile. Sta a noi, oggi, compiere giorno dopo giorno questa scelta. Il Re-Pastore non farà che trarre le conseguenze da quanto abbiamo in questa esistenza scelto liberamente. Dichiarerà ai giusti: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, …» (Mt 25,34); mentre ai Malvagi invece non potrà che dire: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, …» (Mt 25,41)
C’è da aver paura? Sì e no. Sì, perché la vita è un caso serio, unico e irripetibile; no, perché finché c’è vita, c’è speranza di migliorare e cambiare le cose. Ma sta a noi scegliere e non perdere nessuna occasione di bene.
Buon Cammino!
Padre Marco
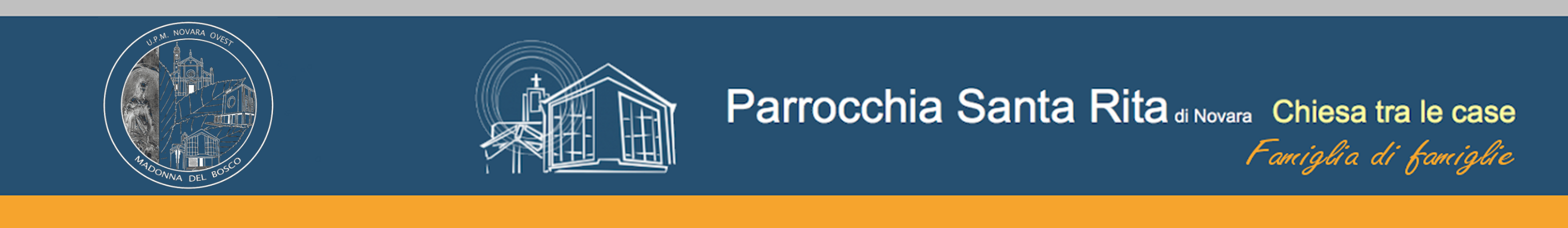
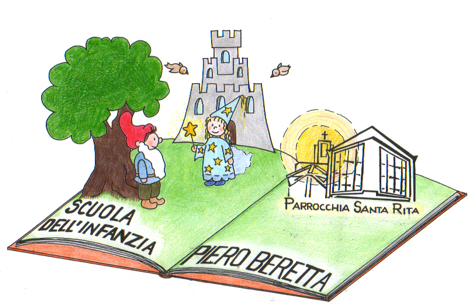










 Users Today : 561
Users Today : 561 Users Yesterday : 1235
Users Yesterday : 1235 This Month : 18251
This Month : 18251 This Year : 85041
This Year : 85041 Total Users : 591130
Total Users : 591130 Views Today : 1702
Views Today : 1702 Total views : 2500650
Total views : 2500650 Who's Online : 11
Who's Online : 11