5 Domande a Mariella Enoc: “Il tempo della relazione è tempo di cura”
 Mariella Enoc, è la Presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dopo gli studi classici e in medicina si è occupata con continuità dell’amministrazione e della gestione di strutture sanitarie. Dal 2012 è procuratore speciale dell’Ospedale Valduce di Como, e lo è stata per dieci anni dell’Ospedale Cottolengo di Torino. È stata presidente di Confindustria Piemonte dal 2008 al 2012, attualmente è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Don Gnocchi e presidente della Fondazione ISMU.
Mariella Enoc, è la Presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dopo gli studi classici e in medicina si è occupata con continuità dell’amministrazione e della gestione di strutture sanitarie. Dal 2012 è procuratore speciale dell’Ospedale Valduce di Como, e lo è stata per dieci anni dell’Ospedale Cottolengo di Torino. È stata presidente di Confindustria Piemonte dal 2008 al 2012, attualmente è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Don Gnocchi e presidente della Fondazione ISMU.
Presidente Enoc, la ringraziamo per aver accettato di dialogare con noi dopo il nostro incontro di formazione in cui erano collegati tanti giovani provenienti da molte parti del Paese. Iniziamo dall’esperienza di questo anno di pandemia: cosa ha visto accadere all’interno delle corsie degli ospedali? «È stato un anno di solitudini, e un momento di confronto come questo assume un’importanza tutta nuova. I giovani hanno sofferto moltissimo, stanno vivendo delle crisi tremende: suicidi continui, disturbi dell’alimentazione aumentati del 40%, e lo stesso si può dire anche per ragazzi non giovanissimi e più adulti. Da molti anni non si manifestavano più pandemie, da molti anni non c’erano più pesti. Perlomeno nel nostro mondo occidentale, in altri Paesi ci sono sempre state. L’Aids in Africa, per esempio, è stata una vera pandemia, ma se ne è parlato poco perché è lontana, perché non ci riguarda da vicino. Noi in Occidente pensavamo di non ammalarci quasi più e che la vita si allungasse, non eravamo assolutamente preparati a un evento di questa portata. Questa è stata la scossa che ci ha dato. Anche nei medici, nei paramedici e in tutti coloro che lavorano in ambito ospedaliero è cambiata la percezione del tempo, la consapevolezza dei nostri limiti; soprattutto è cambiato il nostro rapporto con la morte. La morte nella nostra cultura è diventata un fatto quasi marginale che si vuole nascondere o eliminare. Inoltre, si muore e si cerca di morire soli. Non è più un fatto sociale, è diventata un “accadimento” quanto mai individuale e personale. Ma con il Covid abbiamo assistito a una morte dichiarata. Tutti la vedevano: è stata la morte di una parte della società. Questo è stato lo sconvolgimento. Non soltanto l’emotività di narrare ciò che accadeva, ma anche chiederci quali sono le nostre responsabilità di fronte alla possibilità che nuove epidemie si sviluppino e che nuovi virus strani compaiano. Il covid-19, in questo senso, ci chiede anche una responsabilità personale. Questa esperienza, diminuendo la tecnicalità, ha fatto bene ai medici e agli operatori sanitari perché ha aumentato in loro la conoscenza globale di cosa significhi salvare una persona. Sono dovuti andare in pronto soccorso medici che non erano abituati, come internisti e psichiatri, e grazie a questa esperienza hanno ritrovato la loro vocazione medica globale. Hanno ritrovato il tu per tu con la persona da curare e questo ha fatto in modo che la medicina diventasse più olistica. Non c’era più soltanto un organo da curare, ma una persona con tutte le sue difficoltà, comprese quelle psicologiche, quelle della solitudine del malato». Continua la lettura dell’editoriale a cura de la Redazione di Comunità di Connessioni
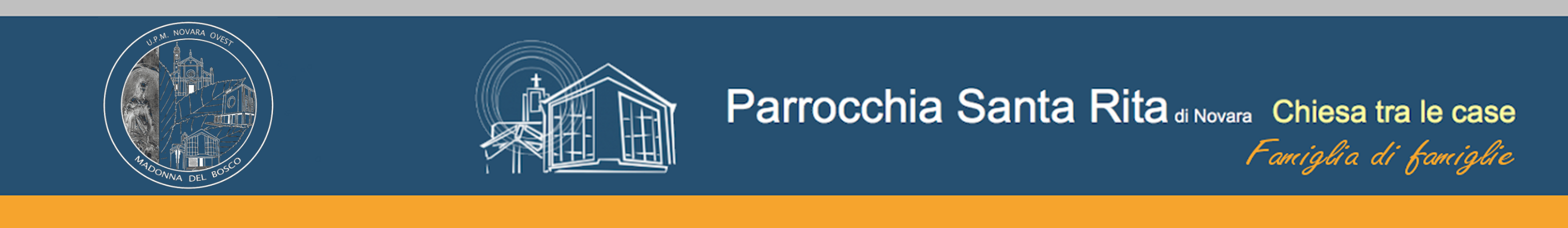
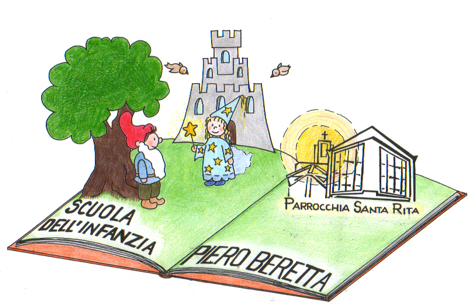









 Users Today : 215
Users Today : 215 Users Yesterday : 1004
Users Yesterday : 1004 This Month : 2026
This Month : 2026 This Year : 68816
This Year : 68816 Total Users : 574905
Total Users : 574905 Views Today : 368
Views Today : 368 Total views : 2440535
Total views : 2440535 Who's Online : 11
Who's Online : 11